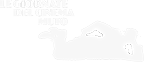FEN DOU
[La lotta]
Dongshan Shi (CN 1932)
Il film cinese Fen dou (La lotta) è stato per decenni considerato perduto. La casa di produzione, la Lianhua, era stata fondata nel 1930 con l’aiuto finanziario del Kuomintang (KMT), il partito nazionalista allora al potere; ispirandosi al modello del LUCE (Unione Cinematografica Educativa), intendeva promuovere coi suoi film il Movimento Nuova Vita. Secondo l’immagine veicolata da tale movimento, i moderni giovani erano atleticamente in forma, sessualmente attraenti ma anche moralmente riservati, e costituivano le componenti meccaniche della più vasta produzione nazionale. Nella sequenza d’apertura del film, per esempio, i due protagonisti, Zheng (interpretato da Djen Jon Lee/Zheng Junli, 1911–1969) e Yuan (Yuan Congmei, 1916–2005), sono presentati come elementi di un ambiente immacolato simile a una macchina. In casa indossano tute da lavoro, indumenti sportivi in stile americano oppure camicie dal taglio perfetto che accentuano il loro fisico atletico. Il personaggio femminile principale, Rondinella (la sedicenne Chen Yanyan, 1916–1999), fa invece parte della famosa Compagnia della Luna Splendente, composta da adolescenti che, abbigliate in costume da bagno o in altra tenuta atletica, intonavano in scena canzoni patriottiche.
L’esercito giapponese invase la Manciuria il 18 settembre 1931 e Shanghai il 28 gennaio 1932. Cineasti e drammaturghi, tra cui Shen Xiling (1904–1940), Tian Han (1898–1968), Xia Yan (1900–1995) e Yang Hansheng (1902–1993), reagirono avviando un dibattito marxista sul cinema e fondando la Lega Cinese dei Drammaturghi di Sinistra, guidata dal Partito Comunista Cinese. Il cinema di sinistra, però, fu talvolta criticato per il suo carattere didattico e per il suo uso, ritenuto troppo intellettuale, del tipo di montaggio proposto da Vsevolod Pudovkin, con una macchina da presa per lo più statica.
In risposta, lo sceneggiatore Huang Jiamo (1916–2004) e lo scrittore e cineasta d’avanguardia Liu Na’ou (1905–1940) esortarono la gente di cinema a prestare maggiore attenzione all’estetica, al ritmo e al rapporto fra realtà e percezione sensoriale. Fedeli seguaci dell’opera degli europei René Clair, Léon Moussinac e F. W. Murnau, Huang e Liu erano convinti che il cinema avesse il potere di porre gli spettatori in una condizione affettiva, come se avessero la sensazione di essere già stati. La risonanza tra le percezioni/le facoltà sensoriali dello spettatore e il milieu emotivo del film consentirebbe allora di instillare nel suo essere fisico un messaggio politico, nella forma di una nuova modalità di coscienza.
Il regista Dongshan Shi (1902-1955) era un membro della Lega dei Drammaturghi. Fen dou testimonia delle sue convinzioni di sinistra da due punti di vista diversi. In primo luogo, la struttura narrativa segue la “lotta” dialettica tra due amici: Zheng, operaio coraggioso, bello, virile e romantico, e Yuan, un altro operaio che, corrotto da brame borghesi come la sete di denaro e di sesso, si comporta da prepotente con i compagni, ma si rivela fragile quando viene chiamato alle armi contro i giapponesi. I due giovani si innamorano della stessa ragazza, Rondinella, che ha subito gli abusi del patrigno. Zheng fugge con Rondinella; i due vanno a vivere in città, ma Yuan riesce a scovarli. I due amici ingaggiano una rissa e vengono arrestati. Alla fine l’invasione giapponese li riunisce: partono entrambi volontari per la guerra, lasciando Rondinella in campagna ad aspettare il loro ritorno. In secondo luogo, l’architettura della vecchia casa che vediamo all’inizio del film verticalizza la lotta di classe tra i proprietari feudali (rappresentati dal patrigno di Rondinella) al piano superiore, la classe operaia a quello intermedio e gli intellettuali trasformati in contadini al piano terra.
Tuttavia, trattandosi di un film commerciale prodotto dalla Lianhua sotto la vigilanza della censura del KMT, Fen dou inserisce questi conflitti sociopolitici in una trama romantica, avvalendosi della splendida fotografia di Zhou Ke. Zhou usa una macchina da presa mobile che riecheggia i movimenti di macchina dei film di Murnau oltre che le tecniche di inquadratura, composizione e montaggio di Pudovkin. La macchina si muove spesso con fluidità intorno ai personaggi, in modo che lo spettatore possa immergersi con loro nella scena. In altri momenti compie una carrellata all’indietro, allontanandosi dai personaggi, in omaggio a un principio estetico della Shanghai dell’inizio del ventesimo secolo: concedere ai personaggi stessi aria (spazio), così da rendere visibili i rapporti di interdipendenza che li legano. Per il film Zhou costruì una struttura a tre piani, in modo da consentire alla macchina da presa di muoversi verticalmente lungo una scala, con funzioni di punteggiatura narrativa nella prima parte del film. Egli impiega inoltre un teleobiettivo, che non solo mette in risalto il fascino degli interpreti, ma permette anche di variare la messa a fuoco con matematica e ritmica precisione per generare sensualità ed emozione.
Fen dou ha una raffinatezza estetica che non trova praticamente l’eguale negli altri film girati a Shanghai in quel periodo e ancora esistenti. Esso veicola idee marxiste ricorrendo a soluzioni formali esteticamente accattivanti. Shi avrebbe raggiunto la fama con gli epici melodrammi postbellici da lui girati verso la fine degli anni Quaranta, e Zheng sarebbe a sua volta divenuto uno dei più importanti cineasti e teorici di Shanghai negli anni Quaranta e Cinquanta. Shi fu premiato al Festival internazionale del cinema di Karlovy Vary nel 1951, ma nel 1955 durante una grande purga contro critici e teorici culturali si tolse tragicamente la vita.
Victor Fan


regia/dir, scen: Dongshan Shi.
photog: Zhou Ke.
cast: Djen Jon Lee/Zheng Junli (Zheng), Yuan Congmei (Yuan), Chen Yanyan (Yan [Rondinella/Swallow]).
prod: United Photoplay Service/Lianhua Film Studio, Shanghai.
première: 29.11.1932 (Shanghai).
copia/copy: DCP, 85′; did./titles: CHI, subt. ENG.
fonte/source: China Film Archive, Beijing.