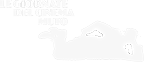IL FAUNO DI MARMO
Mario Bonnard (IT 1920)
Nel 1917 Mario Bonnard affianca alla sua attività di attore quella di metteur en scène. L’esordio dietro la macchina da presa avviene con Treno di lusso, prodotto dalla General-Megale Film di Roma anche se le alterne vicende del film, ritirato dal mercato per problemi di censura, daranno più visibilità alla sua seconda direzione artistica, ovvero L’altro io, prodotto dalla Electa Film di Roma. Queste sue prime esperienze mostrano già l’evidente interesse per i soggetti di derivazione letteraria e un ricercato gusto per storie più complesse, anche di carattere psicologico. Non fa eccezione Il fauno di marmo (1920) una delle ultime produzioni della Celio Film di Roma, entrata già a quell’epoca nel circuito dell’Unione Cinematografica Italiana (U.C.I).
Tratto dal romanzo di Nathaniel Hawthorne, The Marble Faun (1860), lo stesso autore di The Scarlet Letter (1850), Il fauno di marmo è un vorticoso dramma di amore e morte. La principessa Maria (Elena Sangro) sposa per ragioni politiche il duca di Helgoland (Ugo Bazzini). Costui, a capo di un complotto sovversivo, è tenuto sotto controllo dal conte Giorgio (Carlo Gualandri) che s’insinua nella sua casa per smascherarlo. Giorgio cerca di far avvicinare a sé Maria e in una lotta finale con Helgoland, quest’ultimo rimane ucciso dal coltello che Maria gli ha passato. Datisi alla fuga, Maria, adesso sotto lo pseudonimo di Myriam, e Giorgio che è diventato frate, si incontrano a Roma. Giorgio desidera Myriam ma questa lo rinnega e anzi convince un suo pretendente, Donatello (Giorgio Fini) ad ucciderlo. Non è il caso qui di svelare il complesso finale di una trama già articolata.
Da segnalare la presenza dannunziana della Sangro, già protagonista di due titoli fondamentali nella cinematografia italiana, come Fabiola (1918) e La Gerusalemme liberata (1918), entrambi di Enrico Guazzoni, unica attrice di rilievo in questo film. Nelle critiche dell’epoca, poche in verità, si passa dall’entusiasmo del pubblico per il “soggetto originale e romanzesco in modo veramente affascinante che per l’elegantissima messa in scena e l’ottima recitazione”, al “Fauno di marmo. Nessuna novità e niente di lodevole, sia per il soggetto, sia per l’interpretazione”. Le prime proiezioni a Torino, nel settembre 1920, sono seguite da un vasto pubblico che per sei giorni consecutivi, dal 13 al 19, ha affollato il Cinema Ambrosio, uno dei più prestigiosi della città (La Stampa, 16 settembre 1920). I giornali commentano entusiasti i quadri del film che mostrano una Roma inedita, “la città adorata dagli artisti del mondo intero”. La pubblicità del film segnala infatti come, “per la prima volta, e forse unica, si sono girate intiere scene nelle Catacombe di S. Domitilla, nei Musei Capitolini, fra le rovine del Colosseo e perfino nella Basilica di S. Pietro” (L’Arte Cinegrafica, 1919, n. 10). Certamente il gioco tra interni ed esterni appare come un parallelo urbano e architettonico perfetto messo in relazione con i labirintici e complessi rapporti umani dei protagonisti.
Marcello Seregni
Benché la voce che Wikipedia gli dedica sia assai misera, il romanzo di Nathaniel Hawthorne The Marble Faun fu uno dei libri che esercitarono maggiore influenza sui turisti inglesi e americani che giungevano in Italia nel XIX secolo. Opera dominata dal simbolismo e ricca di passaggi descrittivi, era tanto popolare che i turisti andavano alla ricerca dei luoghi frequentati dai personaggi e le guide turistiche di Roma, come Rambles in Rome (Escursioni a Roma) di S. Russell Forbes (1882), indicavano tra i luoghi da visitare la “Hilda’s Tower”, ovvero la cosiddetta Torre della Scimmia. L’adattamento cinematografico di Bonnard – ancor oggi l’unico realizzato – modifica sensibilmente la trama, eliminando le origini per metà ebraiche e potenzialmente incestuose di Miriam, e iniziando la narrazione con un elaborato antefatto in cui ella si trasforma in Maria, “principessa dello Jutland”, per diventare “Myriam” a metà della vicenda. Benché l’unica copia superstite sia incompleta, possiamo notare come Bonnard riesca a sfruttare le ambientazioni romane di Hawthorne, tra cui la succitata Torre e la famosa scena ambientata sulla rupe Tarpea nel Foro; solo nel film, però, Viterbo figura tra i luoghi ove è ambientata la trama.
Jay Weissberg


regia/dir: Mario Bonnard.
sogg: dal romanzo di/from the novel by Nathaniel Hawthorne (The Marble Faun, 1860).
photog: Alessandro Bona.
cast: Elena Sangro (S.A.R. la principessa Maria dello Jutland/H.R.H. Princess Maria; Myriam), Elsa D’Auro (Hilda), Carlo Gualandri (Giorgio; il frate/the monk), Giorgio Fini (Donatello), Fernando Ribacchi (Kenyon), Ugo Bazzini (il duca di/Duke of Helgoland), Carlos A. Troisi, Angelo Gallina, Cav. Giuseppe Piemontesi, Giulio Bagnini.
prod: Celio Film, Rome.
v.c/censor date: 01.03.1920.
copia/copy: DCP, 68′ (da/from 35mm, orig. 1785 m.); did./titles: ITA.
fonte/source: Fondazione CSC – Cineteca Nazionale, Roma.