NANOOK OF THE NORTH (Nanouk) (Nanouk l’esquimese) (US/FR 1922)
Regia di Robert J. Flaherty
Partitura composta e diretta da Gabriel Thibaudeau
Esecuzione dal vivo: quartetto di flauti dell’Orchestra San Marco con le cantanti di gola inuit Lydia Etok e Nina Segalowitz e i solisti Alberto Spadotto e Anna Viola; alle percussioni, Frank Bockius.
L’11 giugno 2022 la comunità Inuit di Inukjuak, cittadina sulla costa orientale della Baia di Hudson in Canada, si è riunita per celebrare il centenario di Nanouk l’esquimese, patrimonio della cultura locale. In mezzo al pubblico c’erano i discendenti del cacciatore Allakariallak (questo il vero nome di Nanouk) e di Robert J. Flaherty. I suoi rapporti intimi con le donne Inuit sono rimasti segreti fino alla morte del regista, compreso quello con Maggie Nujarlutuk ovvero Nyla, moglie fittizia di Nanouk. Trentadue anni dopo la loro relazione, durante l’operazione nota come Canadian High Arctic Relocation, svoltasi nel 1953 e nel 1955, il loro figlio Josephie Flaherty fu deportato insieme alla sua e ad altre famiglie Inuit nell’inospitale Grise Fiord, un villaggio dell’arcipelago artico all’estremo nord del paese. La storia di Josephie è anch’essa parte dell’eredità del film, e un tragico esempio di colonizzazione e industrializzazione forzata in quel territorio (sotto la spinta di governi federali, compagnie del commercio di pellicce, cercatori, missionari, scuole residenziali e così via) ai danni della vita e della cultura Inuit per oltre un secolo, con l’obiettivo di imporre la sovranità, l’assimilazione e gli interessi commerciali della nazione. A dispetto di tante vittime e sofferenze, gli Inuit hanno opposto la loro fiera resistenza, e come dimostra Inukjuak sono ancora in grado di preservare la loro cultura, come hanno fatto dai tempi di Nanouk e prima ancora di allora.
Nanouk l’esquimese fu il risultato di un’eccezionale collaborazione e di una relazione, durata undici anni, fra Robert J. Flaherty e gli Inuit. Prima della sua realizzazione – il film fu girato fra l’agosto del 1920 e quello dell’anno successivo a Port Harrison, ora Inukjuak – Flaherty aveva lavorato per anni nei territori Inuit come cercatore d’oro. Già dalla prima volta in cui aveva portato con sé “uno di quei nuovi marchingegni chiamati macchine da presa” durante la sua spedizione all’isola di Baffin nel 1913 egli si era munito anche di un proiettore allo scopo di mostrare le sue riprese agli Inuit per far sì che, nelle sue parole, “essi lavorassero con me in quanto stretti collaboratori”. Gli Inuit gli fornivano preziosi suggerimenti e gli consigliavano le riprese da effettuare (Robert J. Flaherty, My Eskimo Friends, 1924): “nelle lunghe serate intorno alla stufa accesa nella baracca i miei eschimesi e io parlavamo e pensavamo alle nuove scene da girare”. Flaherty raccolse inoltre, ottenendone ispirazione, i disegni dell’artista Inuit Nungusuituq, sua guida dal 1913 al 1914. Come dimostrano i diari di Flaherty, una delle sequenze del suo film del 1914, prova generale – purtroppo data per dispersa – di Nanouk l’esquimese, era basata su uno di questi disegni, laddove la vicenda di Nanouk era invece ispirata alla vera storia della famiglia dispersa di un cacciatore Inuk, di nome Comok, raccontata a Flaherty dallo stesso Comok nel 1912 o nel 1914. Gli Inuit furono sia “attori consumati“ che “attivi collaboratori” (William Rothman, Documentary Film Classics, 1997) nella realizzazione di questo ritratto multiculturale della vita Inuit; erano anche impegnati con la macchina da presa, ripristinando quando necessario i meccanismi congelati dal freddo e addirittura sviluppando la pellicola sul posto. Ecco perché, nonostante alcuni difetti, stereotipi e inesattezze culturali, il film rivela il genuino talento e l’esperienza degli Inuit ed è da loro considerato tuttora parte integrante della loro storia e della loro cultura.
Gli oltre cinque anni trascorsi a stretto contatto con la cultura Inuit e nei territori Inuit deve avere esercitato un’enorme influenza sulla visione e le pratiche di Flaherty: “dipendevo da loro, rimanevo da solo con loro per lunghi mesi, viaggiavo con loro, vivevo con loro … Tutto il mio lavoro è cresciuto in loro presenza” (“Robert Flaherty Talking”, in Cinema 1950, a cura di Roger Manvell, 1950). Cineasti di etnia Inuit quali Alethea Arnaquq-Baril, regista di Angry Inuk (2016) e Zacharias Kunuk, vincitore della Caméra d’Or a Cannes con il film Atanarjuat: The Fast Runner (2001) nonché fondatore di Isuma, la prima società di produzione canadese interamente di proprietà Inuit, realizzano i loro film seguendo un simile approccio collaborativo: “gli Inuit non lavorano secondo un criterio gerarchico” (Alethea Arnaquq Baril, in imagiveNATIVE. On-screen protocols & pathways, a cura di Marcia Nickerson, 2019). Isuma si prefigge di instillare valori culturali di rispettosa collaborazione, sostegno alla comunità, e partecipazione collettiva nel processo di produzione dei propri film, in opposizione all’individualismo e alla competizione. Norman Cohn, direttore della fotografia e co-fondatore di Isuma, sostiene che la maniera Inuit di fare cinema è “la maniera Inuit di fare tutto quanto… un po’ come la caccia alla foca”. “Secondo la sensibilità Inuit, le cose importanti che realizzi nella vita sono quelle che fai lavorando insieme” (Norman Cohn, intervista a IsumaTV, 2008). Benché Nanouk sia stato prodotto un secolo fa in un contesto coloniale e perciò mercantile, questa sensibilità Inuit e la sua traduzione in metodo di lavoro è pienamente riflessa nel modo in cui il film è stato realizzato.
Mai prima di Nanouk l’esquimese la vita, le storie e le attività culturali delle “persone reali“ erano state plasmate in termini così creativi come resoconto drammatico per immagini, interpretato e ricreato da queste stesse persone. “Per la prima volta, in Nanouk, assistiamo alla vita reale come forma di narrazione” (Brian Winston, The Documentary Film Book, 2013). Per molti, questo film segna la nascita del cinema documentario, di ciò che John Grierson definì più tardi come “il trattamento creativo della realtà”. I cento anni di Nanouk l’esquimese ci invitano a riconoscere il contributo degli Inuit alla sua realizzazione e a guardare il film come risultato di uno sforzo comunitario, alle origini di un approccio genuinamente collettivo al cinema documentario. Per dirla con Flaherty, “in fin dei conti è tutta una questione di rapporti umani” (Robert J. Flaherty, 1950).
Francesco Rufini
La musica A 45 gradi sotto zero i suoni si percepiscono a malapena: con un freddo del genere non potrebbero andare lontano. Eppure, per più di diecimila anni, gli Inuit hanno ascoltato il vento che accarezza la neve, l’ululato dei cani, lo scricchiolio dei pattini delle slitte, le grida di migliaia di oche selvatiche in volo all’arrivo dell’autunno, lo scrosciare dei fiumi in primavera. Ascoltano la voce degli anziani, portatori di saggezza; la voce dei bambini, portatori di speranza. E il silenzio. L’assordante silenzio.
E poi i Kabloonak, i bianchi, con le loro grandi vele, le loro enormi navi; e le loro macchine da presa.
C’è un passatempo che appassiona gli Inuit durante le lunghe notti polari. Si chiama Katajak, un gioco vocale in cui le donne, una di fronte all’altra, si passano le voci ritmicamente, rimbalzandole a vicenda fino a scoppiare in una gran risata! Raccontano così il proprio universo. Guarda caso, le loro canzoni si chiamano “Il cane“, “Il fiume“, e così via.
Questa partitura per Nanouk riecheggia il loro gioco saltando da uno strumento all’altro, volteggiando come neve nel sole in controluce. Quattro flauti rispondono a quattro cantanti, due Kabloonak e naturalmente due Inuit. I due quartetti sono punteggiati dalle percussioni: ora meditative, ora ansimanti. Ho tentato così, con questi respiri condivisi, di celebrare l’indicibile gioia di essere vivi, di porgere un tributo alla forza indimenticabile nel sorriso di Nanuk.
È ovvio che questo concerto non potrebbe avere luogo senza la generosa collaborazione di Nina Segalowitz, Lydia Etok, e dei musicisti dell’Orchestra San Marco di Pordenone. Tutti meritano la nostra gratitudine.
Nakurmiik! (Grazie, in lingua Inuktitut.)
Gabriel Thibaudeau

NANOOK OF THE NORTH (Nanouk) (Nanouk l’esquimese) (US/FR 1922)
regia/dir: Robert J. Flaherty.
scen: Robert J. Flaherty, Frances H. Flaherty.
did/titles: Carl Stearns Clancy, Robert J. Flaherty.
photog: Robert J. Flaherty, asst. “Harry Lauder”, Bob Stewart.
mont/ed: Carl Stearns Clancy, Robert J. Flaherty, Charles Gelb.
cast: Allakariallak (Nanook), Maggie Nujarlutuk (Nyla), Cunayou (la figlia/the daughter), Philipoosie (Allegoo, il figlio/the son), Bob Stewart (il commerciante/trading post agent).
prod: Robert J. Flaherty, Revillon Frères.
dist: Pathé Exchange.
uscita/rel: 11.06.1922 (Capitol Theatre, New York).
copia/copy: DCP, 85′; did./titles: ENG.
fonte/source: Library & Archives Canada, Ottawa.
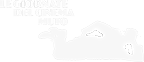

 English
English