GUOFENG (CN 1935)
[Costumi nazionali]
Regia di Lo Ming Yau/Luo Mingyou, Chu Shek-lin/Zhu Shilin
Musica di Gabriel Thibaudeau
Guofeng (Costumi nazionali), prodotto dalla United Photoplay Service (UPS, nota anche con la denominazione di Lianhua Film Company), è l’ultima interpretazione della leggendaria Lily Yuen (Ruan Lingyu, 1910-1935) che si tolse la vita all’inizio di marzo del 1935, circa due mesi prima dell’uscita del film a Shanghai.
Dal 1926 al 1928 il Kuomintang (KMT o Partito Nazionalista) condusse la Spedizione del Nord nel tentativo di spezzare il dominio dei signori della guerra e unificare le regioni costiere della Cina orientale. Sotto la guida di Chiang Kai-shek (1887-1975) i quadri del partito avviarono il movimento Nuova Vita, teso a promuovere quattro valori nazionali mutuati dal confucianesimo e dal protestantesimo evangelico: (1) li, trattarsi reciprocamente secondo le norme di cortesia dei riti sociali; (2) yi, assolvere le proprie responsabilità sociali e politiche e rispettare il proprio ruolo nella gerarchia sociale; (3) lian, praticare la frugalità; (4) chi, nutrire un consapevole senso del pudore. Nel 1930, sotto la diretta guida di un ente italiano come il LUCE – L’Unione Cinematografica Educativa, il KMT finanziò la fusione di quattro case cinematografiche di Shanghai per costituire l’UPS e sfruttare così il cinema come strumento educativo.
Guofeng narra la vicenda di due sorelle provenienti dalla campagna, Zhang Lan (Yuen) e Zhang Tao (Li), che terminate le scuole superiori seguono percorsi diversi. Lan sacrifica l’amore e ottiene una borsa di studio per frequentare l’università a Shanghai, ove si attiene ai quattro principi del Movimento Nuova Vita e diventa una perfetta attivista nazionalista. Tao sposa invece il fidanzato mancato di Lan e frequenta l’università grazie al sudato stipendio di insegnante di lui; ama la vita sociale e infine divorzia dal marito, spinta dal desiderio di piaceri materiali.
Il contesto ideologico del film ci può lasciare disorientati, se non teniamo presenti le condizioni storiche della Cina negli anni Trenta. Le invasioni giapponesi in Manciuria (18 settembre 1931) e a Shanghai (28 gennaio 1932), spinsero i cineasti ad abbracciare il socialismo (aderendo al partito comunista cinese o PCC) oppure il nazionalismo (nelle file del KMT). Nonostante le posizioni polarizzate, entrambi i partiti propugnavano (1) l’antimperialismo; (2) l’anticapitalismo (nelle aree urbane della Cina il capitalismo era arrivato a braccetto col colonialismo); e (3) l’antifeudalesimo (drenando dalle zone rurali cospicue risorse naturali e umane, le imprese europee ed americane favorivano lo sviluppo nelle campagne di una struttura economica di tipo feudale distruggendo l’economia rurale cinese). Pertanto, nell’immaginazione popolare come tra i cineasti, i valori del socialismo e del nazionalismo si intrecciavano spesso all’insegna di “un’arte, una letteratura e un cinema di difesa nazionale”.
Il cineasta socialista giapponese Akira Iwasaki (1903-81), che visitò Shanghai nel 1935, notò un forte incremento di film favorevoli al KMT realizzati nel biennio 1934–35, in parte anche a causa dell’irrigidirsi del sistema di censura introdotto dal partito. A suo avviso, Guofeng era un efficace esempio dei film promossi dal Movimento Nuova Vita per sostenere posizioni rigidamente ostili alla modernità. Anche lo studioso Xiao Zhiwei scorge nel film una intransigente condanna della bellezza femminile urbana quale simbolo di corruzione coloniale e capitalistica e di reificazione sessuale: una situazione che può trovare riscatto solo con le donne che ritornano in campagna e contribuiscono alla ricostruzione dell’economia rurale.
Tuttavia, come sostiene lo studioso Evans Chan, Guofeng non si può ridurre a un manuale di propaganda del KMT. Il regista Chu Shek-lin (Zhu Shilin, 1899-1967) apparteneva a una generazione di artisti ancora affascinata dall’eleganza e dalla sensibilità estetica dei “vecchi” intellettuali. In Guofeng questa fascinazione è attestata non solo dalla raffinatezza delle scenografie, dei costumi e della messinscena, ma anche dalla mobilità della macchina da presa, che alterna quiete e movimento, e spazializza l’immagine filmica come un viaggio o un processo del divenire. Negli anni Ottanta Lam Nin-tung, studioso di cinema di Hong Kong, osservava che le inquadrature di Chu sono paragonabili a un dipinto su rotolo dell’epoca delle Sei Dinastie (220/222-589 d.C.). La disposizione delle figure umane e degli oggetti nell’inquadratura è pensata strategicamente per aiutare gli spettatori ad allacciare con essi un rapporto affettivo. Chu ama anche usare piante, finestre dal delicato profilo o mobili per ostruire parzialmente la visione o indirizzare lo sguardo, attirando così l’attenzione degli spettatori verso il centro dell’inquadratura. Questo modo di inquadrare invita gli spettatori ad aprire la propria mente al rapporto tra i personaggi e il più vasto mondo fuori campo (la famiglia, la società e perfino la nazione) che rimane al di fuori dello schermo.
Chan osserva pure che Chu condivide il concetto nietzschiano di “transvalutazione” – una completa reinterpretazione di tutti i valori esistenziali e morali. Per lui, rapporti improntati a benevolenza, compassione, empatia, equanimità sono possibili solo quando tutti i personaggi raggiungono parità di condizioni sul piano esistenziale. Secondo Chan, i messaggi rigidamente antimoderni del film – resi soprattutto attraverso il corpo femminile e il modo in cui esso viene sessualizzato – si devono interpretare come un tentativo di spogliare tutti i personaggi delle differenze di genere, dei ruoli sociali obbligati e dei doveri istituzionali (come il matrimonio eterosessuale) per iniziare a gettare le basi di una qualche forma di comprensione reciproca.
Il concetto di transvalutazione era apprezzato da Lily Yuen, l’attrice cinese più contesa dell’epoca. Nel 1933 ella ruppe troncò la relazione che aveva da tempo con Chang Ta-min (Zhang Damin), il quale la querelò, chiedendo un risarcimento finanziario. In quel periodo, il suo legame sentimentale con il mercante di tè Tang Chi-shan (Tang Jishan, 1896-1967) era già finito sui tabloid. Chu, come molti altri registi che la diressero, fece in questo film un appropriato commento sulle pressioni da lei allora sopportate. Finì che l’attrice si uccise alle due del mattino dell’8 marzo 1935, ingerendo una dose eccessiva di barbiturici. Le sue ultime parole furono “ren yan ke wei” (i discorsi umani [o i pettegolezzi] sono [veramente] terribili).
Victor Fan

GUOFENG (CN 1935)
[Costumi nazionali / National Customs]
regia/dir, scen: Lo Ming Yau/Luo Mingyou, Chu Shek-lin/Zhu Shilin.
photog: Hong Weilie.
exec prod: Lay Min Wei/Li Minwei (M. W. Ray).
scg/des: Zhang Hanchen.
prod mgr: Xing Shaomei.
cast: Lily Yuen/Ruan Lingyu (Zhang Lan), Li Lili (Zhang Tao), Lin Chuchu/Cho-cho Lam (Zhang Jie), Djen Jon Lee/Zheng Junli (Chen Zuo).
prod: United Photoplay Service (Lianhua Film Company), Shanghai.
première: 05.1935 (Shanghai).
copia/copy: streaming digital file, 104′; did./titles: CHI.
fonte/source: China Film Archive, Beijing.
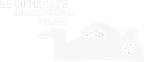

 English
English